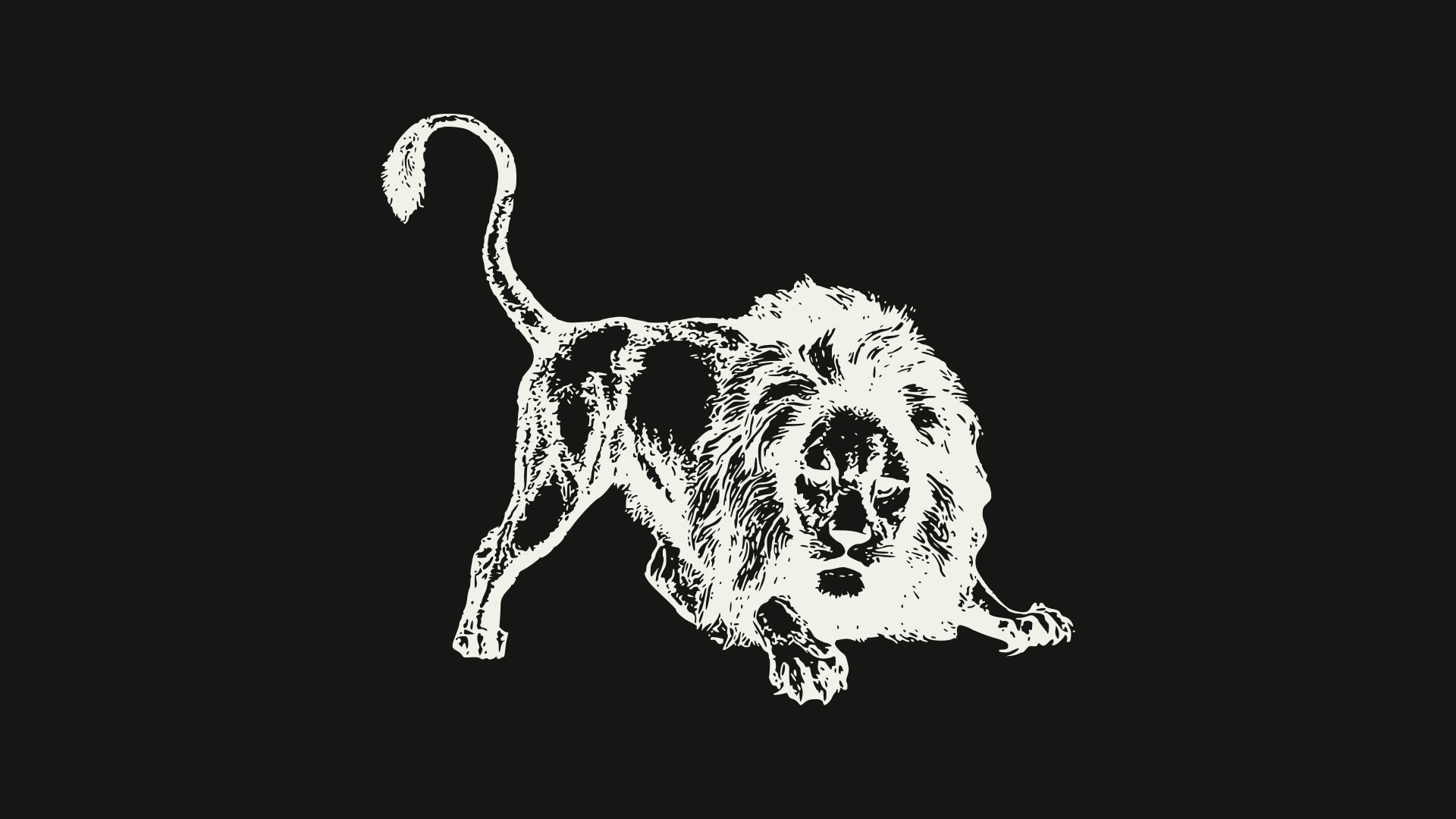
L'incontro di questa settimana si è concentrato sullo studio dei centri di potere, definito provocatoriamente
come l'“Antropologia dei Cattivi”. L'obiettivo era riflettere sulla necessità di includere le élite e le
istituzioni dominanti tra i soggetti d'indagine, sovvertendo un'impostazione storica della disciplina che ha
privilegiato i gruppi marginalizzati.
L'incontro si è svolto in forma di tavola rotonda partecipativa. Alessandra e Fabiana hanno chiesto ai
partecipanti di scrivere su post-it riflessioni, parole chiave o definizioni sul tema dell'antropologia dei
cattivi, che sono state successivamente lette e utilizzate come punti di partenza per la discussione.
Un invito a studiare il potere
Una delle principali fonti discusse è stata Up the Anthropologist—Perspectives Gained from Studying Up, il saggio di Laura Nader pubblicato nel 1972. Nader invita gli antropologi e le antropologhe a rivolgere la loro attenzione verso l'alto, analizzando il potere e le sue manifestazioni all'interno delle istituzioni politiche, economiche e burocratiche. Questo approccio non solo amplifica la comprensione delle dinamiche sociali, ma pone domande fondamentali sulle responsabilità etiche della disciplina e sul suo ruolo nel promuovere un cambiamento sociale.
Rodolfo Stavenhagen, con il suo saggio La decolonizzazione delle scienze sociali applicate (in “Antropologia Applicata. Problemi e Prospettive” di Roberto Malighetti, 2020), è stato un altro riferimento chiave. Stavenhagen sottolinea l'importanza di liberare l'antropologia dalle sue radici coloniali e di utilizzarla come strumento per decostruire le gerarchie epistemologiche che privilegiano una visione occidentale del mondo. Richiama la necessità di includere le élite tra gli oggetti di studio per comprendere i meccanismi di mantenimento e trasformazione del potere:
"La vera comprensione delle forze sociali in un processo di cambiamento sociale richiede più che un'analisi dei cosiddetti gruppi sociali non privilegiati [...] È necessario che l'antropologia rompa con il proprio passato e si incammini verso nuovi sentieri."
Un esempio concreto è il lavoro di Karen Ho, autrice di Liquidated: An Ethnography of Wall Street (2009), che ha analizzato le banche d'investimento di Wall Street integrandosi nel contesto lavorativo come tirocinante. Questa strategia le ha permesso di osservare direttamente le pratiche e le ideologie che governano il capitalismo finanziario, offrendo una prospettiva interna sui sistemi di potere.
Colonialismo, epistemologia e immaginario
Una riflessione centrale è stata quella sul legame tra antropologia e colonialismo. Latour mette in discussione il concetto stesso di distanza tra ricercatore e soggetto, sottolineando come l'antropologia debba abbandonare approcci che riproducono l'esotismo e l'orientalismo. La sfida, sostiene Latour, è rinnovare gli strumenti metodologici per studiare il mondo contemporaneo senza trattare i propri simili come “esotici”:
"Pourtant, une fois la minute d'amusement passé, une fois effacé le sourire narquois, une telle attitude n'aboutirait qu'à cette forme détestable d'exotisme qu'on peut appeler l'occidentalisme [...] Si elle veut étudier son propre monde, l'anthropologie doit accepter de se rééquiper de fond en comble, comme un explorateur parti en expédition pour les Tropiques qu'un coup du sort obligerait à découvrir les fjords du Cap Nord."
Laura Nader, in Naked Science. Anthropological Inquiry into Boundaries, Power, and Knowledge (1996), esplora come i sistemi di sapere occidentali abbiano sistematicamente marginalizzato altre forme di conoscenza. Questo tema è stato collegato al concetto di “colonizzazione dell'immaginario”, per descrivere come i modelli culturali dominanti tendano a imporsi come unici e universali. I partecipanti hanno discusso come un'analisi critica delle élite possa aiutare a decostruire queste narrative, evidenziando che molte realtà apparentemente immutabili, come il capitalismo globalizzato, sono in realtà il risultato di costruzioni storiche e culturali. Questo approccio, oltre a fornire strumenti teorici, offre possibilità pratiche per immaginare alternative socioeconomiche.
Accesso al campo e rotture metodologiche
Uno dei temi più dibattuti è stato quello delle difficoltà metodologiche nello studio dei centri di potere. L'accesso ai campi di ricerca elitari è spesso limitato, sia per la resistenza dei soggetti studiati sia per le dinamiche interne alle istituzioni. Un esempio rilevante è quello di Partecipare all'impresa globale. Una ricerca antropologica in Automobili Lamborghini (2021) di Fulvia D'Aloisio, un lavoro che ha esplorato il sistema di gestione dei lavoratori in un'azienda multinazionale attraverso la collaborazione con il dipartimento universitario della ricercatrice. Questa esperienza ha messo in luce i compromessi necessari per ottenere accesso senza compromettere l'integrità della ricerca. Alessandra ha condiviso un'esperienza personale legata alla difficoltà di osservare le dinamiche interne di una rete di mercati sostenibili (L'Alveare che dice Si). Nonostante il mancato accesso, questa situazione ha portato alla riflessione sull'efficacia dell'osservazione partecipante in contesti aziendali e istituzionali, dove spesso si percepisce l'antropologo come un intruso.
Laura Nader ha sottolineato come l'osservazione partecipante, pilastro dell'antropologia classica, sia spesso inefficace in ambienti istituzionali, come aziende o governi:
"The most usual obstacle is phrased in terms of access. The powerful are out of reach on a number of different planes: they don't want to be studied; it is dangerous to study the powerful; they are busy people [...] The stealth of the corporation is epitomized in those wily chess masters they employ to handle their cases, the corporate lawyers."
Pierre Bourdieu, citato nel lavoro di D'Aloisio, propone un approccio alternativo chiamato “oggettivazione partecipante”. Questo metodo non si limita a osservare il campo, ma analizza le condizioni sociali che rendono possibile l'atto stesso di osservare:
"L'oggettivazione partecipante non è la mera oggettivazione dell'antropologo che produce l'analisi antropologica di un mondo a sé estraneo, ma piuttosto è l'insieme del mondo sociale che ha prodotto, allo stesso tempo, l'antropologo e la sua prospettiva antropologica."
Il dibattito si è esteso al ruolo politico dell'antropologia. David Graeber è stato citato come esempio di antropologo militante, il cui lavoro ha cercato di mettere in discussione le strutture di potere dominanti. Tuttavia, molti partecipanti hanno evidenziato la tensione tra l'impegno politico e il rigore accademico.
Si è discusso anche del “realismo capitalista”, un concetto elaborato da Mark Fisher, che descrive il capitalismo come unico sistema pensabile. L'antropologia, si è detto, deve contribuire a smascherare questa narrativa, ampliando lo spettro delle possibilità immaginabili e delle soluzioni praticabili.
Stavenhagen ha poi offerto spunti sull'etica della ricerca e sull'importanza della restituzione del sapere. Richiamando Paulo Freire, ha sottolineato come il dialogo tra ricercatore e soggetti studiati possa trasformare la ricerca in un processo di apprendimento reciproco:
"Questo [...] è ciò che Paulo Freire chiama dialogia nella Pedagogia degli Oppressi. [...] La conoscenza è necessariamente relativa, a volte ambigua e soggetta a costanti revisioni; può diventare ideologia se usata come guida all'azione."
Questo approccio ha trovato eco nelle esperienze condivise dai partecipanti, che hanno evidenziato la necessità di bilanciare la trasmissione della conoscenza con la creazione di uno spazio di confronto e crescita collettiva.
Un'antropologia critica e trasformativa
L'incontro si è concluso con una riflessione collettiva sulla necessità di ripensare l'antropologia come
disciplina critica e trasformativa. L'analisi dei centri di potere richiede di affrontare sfide metodologiche,
epistemologiche ed etiche, ma offre anche una straordinaria opportunità di rinnovamento per la disciplina.
L'invito a “studiare verso l'alto”, formulato da Laura Nader, e l'esortazione di Rodolfo Stavenhagen a rompere
con le limitazioni coloniali, pongono le basi per un'antropologia che non si limiti a documentare le
disuguaglianze, ma cerchi di comprendere le strutture che le producono e le perpetuano. Questo approccio non è
privo di difficoltà: l'accesso ai contesti elitari è spesso ostacolato dalla riluttanza delle élite a essere
studiate, come evidenziato nella riflessione di Nader sull'opacità delle grandi corporazioni e dei loro
rappresentanti legali.
Tuttavia, come emerso dal dibattito, tali difficoltà non devono scoraggiare i ricercatori, ma stimolarli a
sperimentare nuove metodologie. La “oggettivazione partecipante” di Bourdieu, ad esempio, suggerisce che il
ricercatore non possa separarsi dal contesto sociale che lo ha prodotto, ma debba utilizzare questa
consapevolezza per arricchire la propria analisi. In parallelo, il concetto di dialogia di Freire, ripreso da
Stavenhagen, invita a trasformare la ricerca in un processo di apprendimento reciproco, dove il sapere
prodotto non sia unidirezionale, ma frutto di una collaborazione autentica con i soggetti studiati.
Un altro punto cruciale è il ruolo della restituzione del sapere. Gli antropologi e le antropologhe non
possono più permettersi di ignorare l'impatto delle loro ricerche sulle comunità studiate e sulla società in
generale. La teoria, come osserva Stavenhagen, diventa una forza materiale quando si traduce in pratiche che
influenzano positivamente la vita quotidiana. In questo senso, l'antropologia dei centri di potere ha il
potenziale di contribuire a una maggiore trasparenza e responsabilità nelle strutture dominanti, offrendo
strumenti per comprendere e, in alcuni casi, per trasformare le dinamiche sociali.
Infine, l'incontro ha sottolineato l'importanza di mantenere aperto il dialogo tra accademia, istituzioni e
pubblico. Solo attraverso un continuo scambio di idee e approcci sarà possibile costruire un'antropologia che
risponda alle esigenze del mondo contemporaneo, bilanciando rigore accademico e impegno politico.
L'antropologia dei “cattivi” non è solo una sfida teorica e metodologica, ma anche un'opportunità per
ripensare il ruolo della disciplina nel costruire una società più equa e consapevole.