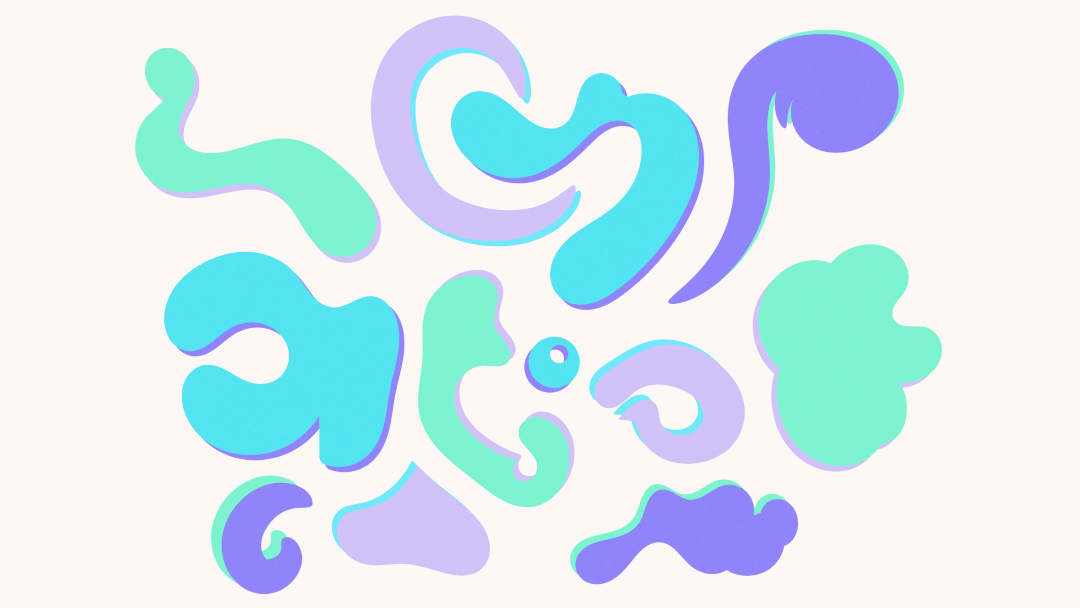
“Nuove Antropologie” è un ciclo di incontri che abbiamo pensato con l'obiettivo di dare spazio a dialoghi su alcune delle direzioni della ricerca antropologica che non sempre trovano risalto negli studi canonici sulla disciplina.
Il seminario si sviluppa intorno a due domande principali che attraversano tutti gli incontri: in cosa consiste questo approccio? e quale contributo particolare offre questo approccio all'antropologia?
L'antropologia multispecie non rappresenta un filone di studi unificato ma raccoglie diverse esperienze molto variegate fra loro; per questo abbiamo deciso di adottare il plurale per riferirci all'approccio adottato in questo incontro. Inoltre, il discorso è sbilanciato verso il campo dell'americanistica ma le antropologie multispecie esistono e possono esistere in ogni angolo della disciplina.
Quando si parla di antropologie multispecie, assemblaggi di umani e non-umani, e i vari altri concetti che toccheremo, non si può non far riferimento ad alcuni autori che hanno costituito, per molti aspetti, le premesse di questo filone di studi soprattutto in ragione del loro contributo nella cosiddetta svolta ontologica.
Bruno Latour, in “Non siamo mai stati moderni” (1991), pone dei dubbi importanti sullo statuto della scienza e sulla nostra relazione con la dimensione oltre-che-umana, evidenziando l'illusorietà di una divisione netta fra scienze che studiano solo la natura e discipline che studiano solo gli esseri umani, le loro relazioni e i loro prodotti. Questa distinzione si basa sull'opposizione tra l'idea di unicità della natura e di molteplicità delle culture posta a fondamento della scienza moderna senza però che si sia mai effettivamente realizzata. Ciò che possiamo osservare è piuttosto una proliferazione di quasi-oggetti intrinsecamente ibridi (embrioni congelati, buco nell'ozono, virus…), prodotto di “collettivi” di nature-culture. Le antropologie multispecie possono essere considerate per diversi aspetti uno sviluppo dell'antropologia simmetrica proposta da Latour, che immaginava come un'antropologia capace di superare la sua attitudine a focalizzarsi esclusivamente sull'umano. Latour, negli stessi anni, aveva anche sviluppato la Actor-Network Theory (ANT) (Johnson, 1988), che mette l'accento sulla presenza di una rete di interazioni in cui gli attori che partecipano appartengono a tutte le sfere del reale; ed è questa rete che gli antropologi devono studiare.
Eduardo Viveiros De Castro, durante un ciclo di lezioni tenute nel 1998 (2019), espone la sua teoria del prospettivismo cosmologico fondato sul multinaturalismo, concetto formulato a partire dalle sue ricerche etnografiche e da quelle di altri/e antropologi/ghe, tra cui spiccano i lavori di Tania Stolze Lima e Aparecida Villaça. In diverse cosmologie indigene, non solo di area amazzonica, si può riscontrare un'inversione rispetto alle idee della modernità, ovvero una pluralità di nature a fronte dell'unicità della cultura. C'è l'idea, quindi, di una soggettività condivisa fra gli esseri che vivono nel mondo; il concetto di “umano” non è isolabile alla nostra sola specie e le nature, i corpi, diventano gli elementi di variabilità che modificano il proprio stare nel mondo.
Philippe Descola, in “Oltre natura e cultura” (ed. or. 2005), discute il modo in cui, in collettivi natural-culturali diversi, definiamo contestualmente il confine identitario, di natura ontologica, fra umano e non-umano nella molteplicità di collettivi.
Tim Ingold è considerato fra i principali autori di questo cambio di paradigma chiamato “svolta ontologica”. Rispetto agli autori precedenti, parte da un altro retroterra teorico, quello dell'antropologia ecologica, sviluppatasi negli anni Sessanta come unione dei saperi delle scienze naturali con quelli antropologici al fine di mostrare l'influenza dell'ambiente sulla cultura. Questo ambito di studi, per lungo tempo focalizzato sui flussi e gli scambi di energia, influenza la priorità che attribuisce al carattere relazionale degli ambienti. Nel 2000, quando pubblica “La percezione dell'ambiente”, si concentra sulla dimensione percettiva, che rappresenta allo stesso tempo il luogo in cui si manifesta lo scarto fra le esistenze e il canale di interconnessione che porta alla formazione di reti di esistenti.
Di autori e autrici che possiamo citare per parlare di antropologie multispecie ce ne sono tanti perché non si tratta di una scuola di pensiero unitaria. Stiamo parlando soprattutto di una rete diffusa di idee, concetti e influenze che pongono l'accento sulla nostra relazione con l'ambiente, con ciò che ci circonda e con cui interagiamo costantemente. Prima ancora delle idee, come abbiamo visto, l'interazione passa per i sensi e la percezione.
Non possiamo parlare di relazione ambientale senza parlare dell'Antropocene, di quest'idea che la presenza umana sul pianeta abbia raggiunto un impatto paragonabile a quello degli agenti geologici. Diventano ora importanti le questioni di scala perché, se gli esseri umani hanno un impatto sul macro-ambiente, gli antropologi non possono più limitarsi a osservare e studiare il micro-ambiente del campo. Le differenti scale in gioco riguardano anche il tempo, richiedono uno sguardo sul lungo periodo per poter cogliere le configurazioni interattive dei collettivi. Nel 2007, Donna Haraway evidenzia le interrelazioni che uniscono le specie, andando contro l'idea di un eccezionalismo umano, e richiama la necessità di considerare gli assemblaggi come un nuovo, fondamentale oggetto di studio. Assemblaggi come reti che uniscono diverse scale spaziali e temporali, diverse agentività, diversi modi di stare nel mondo, diverse politiche ed economie.
Fra le tante etnografie multispecie, citiamo “Come pensano le foreste” di Eduardo Kohn (2013), sulla comunicazione transpecie, e “Il fungo alla fine del mondo” di Anna Tsing (2015), sulle connessioni che si sviluppano nella filiera di raccolta dei funghi matsutake. Al centro di entrambe troviamo assemblaggi complessi, analizzabili solo parzialmente, possibili solo nell'interazione fra percezioni diverse.
L'Antropocene ci parla anche della fine e della sua paura, ma soprattutto della precarietà come carattere comune alle esistenze. Le reti si annodano e si disfano nelle interazioni e le etnografie multispecie ci mostrano le alternative che possono emergere da questo processo.
Bibliografia per approfondire
- Borgnino, Emanuela. 2022. «Ecologie native». Milano: Elèuthera.
- Castro, Eduardo Viveiros de. 2019. «Prospettivismo cosmologico in Amazzonia e altrove: quattro lezioni tenute presso il Department of Social Anthropology, Cambridge University, febbraio-marzo 1998». A cura di Roberto Brigati. Macerata: Quodlibet.
- De Chadarevian, Soraya, e Roberta Raffaetà. 2021. «COVID-19: Rethinking the Nature of Viruses». History and Philosophy of the Life Sciences 43 (1): 2.
- Descola, Philippe. 2021 [2005]. «Oltre natura e cultura». A cura di Nadia Breda. Tradotto da Annalisa D'Orsi. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Haraway, Donna. 2007. «When Species Meet». Minneapolis: Univ. of Minnesota Press.
- Ingold, Tim. 2022 [2000]. «The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill». New edition. London: Routledge.
- Johnson, Jim [alias di Bruno Latour]. 1988. «Mixing Humans and Nonhumans Together: The Sociology of a Door-Closer». Social Problems 35 (3): 298-310.
- Kohn, Eduardo. 2007. «How Dogs Dream: Amazonian Natures and the Politics of Transspecies Engagement». American Ethnologist 34 (1): 3-24.
- Kohn, Eduardo. 2021 [2013]. «Come pensano le foreste. Per un'antropologia oltre l'umano». Tradotto da Alessandro Lucera e Alessandro Palmieri. Roma: Nottetempo.
- Latour, Bruno. 2018 [1991]. «Non siamo mai stati moderni» [Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique]. Milano: Elèuthera.
- Latour, Bruno. 2017 [2015]. «Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime». Tradotto da Catherine Porter. Cambridge, UK Medford, MA: Polity.
- Tsing, Anna Lowenhaupt. 2021 [2015]. «Il fungo alla fine del mondo. La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo». Tradotto da Gabriella Tonoli. Rovereto: Keller.